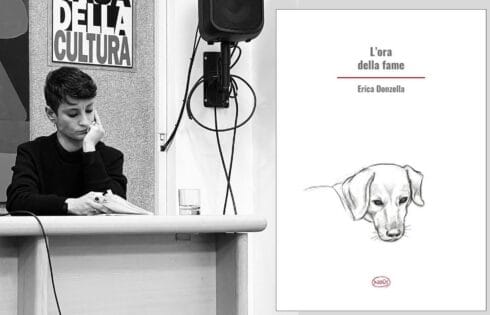Silvia Rosa, L’ombra dell’infanzia (peQuod 2025, postfazione di Franca Alaimo)
Un’ape allucinata che sbatte contro i vetri,
febbre che arrossa le guance, notte che
batte sui denti cariati. Sono questi i mali
rappresi in segni violacei sul rosa
delle albe d’infanzia, i guasti delle
lucciole che muoiono discrete sotto una
brina spessa. Io vorrei dire invece
lo strappo delle ali che buca la schiena,
la perdita del corpo un pezzo dopo l’altro
sotto il peso di un nome di fango e resina,
che lascia addosso un’onta indelebile
e in gola un fiore di spavento: vorrei
raccontare di come cresce nelle sere
di luna piena, cambiando colore e di come
diventano le mani di una bambina quando
scavano in bocca una fossa di silenzio.
*
In un quartiere popolare i palazzi sono
alte torrette di guardia, occhiute, in cui
si annidano parole feroci e l’odore
del latte e caffè che sborda da pentolini
anneriti. Al cospetto delle loro ombre,
la bambina impugna la sua bici e pedala
lontano, precaria, verso un lembo di piazza
spopolata, asfalto e rifiuti, dopo il mercato
rionale. Le ore scardinate e messe in pausa,
la tregua al sapore di Big Babol panna e
fragola che si mischia alla saliva amara,
ruggire piano, sentirsi peso piuma contro
le ingiurie che a casa sbottano improvvise,
poi l’inciampo, l’urto, la scorza delle mani
sbucciata, le ginocchia in fiamme, una fitta
a fior di pelle, accucciata a terra la bambina
non piange, attende che il dolore passi,
si fa gomitolo e poi biglia e immagina
di risplendere nell’aria pallida di giugno,
veloce come scheggia, sfaccettata,
un festoso globo di vetro disossato, un sole
precipitato nell’indifferenza di tutti.
*
C’era una volta una bambina e c’erano
con lei le sue sorelle di sventura, tutte sole
in un bosco blu cobalto, nell’ora in cui scocca
la tormenta. Nel fragore ultraterreno dei tuoni
e nel fiammeggiare del cielo viola, vagavano
senza battesimo nella chiarissima certezza
che se dio esiste, non è per loro. Una supernova
atterrata con clamore nella radura più cupa
– una pluviale valle di lacrime mai versate, se non
nel segreto di una stanza chiusa – proiettava
intorno un brillamento da guerra nucleare,
un trilione di lucciolii da dare il vomito. La fauna,
persino il lupo dai denti aguzzi, stava alla larga,
del resto la schiera delle bimbe era un vibrante
esercito di fantasmi. Una foschia si alzò dal verde
marcio in cui affondavano i talloni e nella spirale
del mese di maggio si aprì una voragine, la vigilia
boreale di un passaggio, altrove. Sorelle, non c’è
una ragione se è capitato a noi questo morire restando
in piedi, abbarbicate alla cima delle nostre storie
amare. Ma per il lieto fine non occorre alcun
lasciapassare, è già nostro, l’abbiamo barattato
con l’ombra dell’infanzia in cui ci siamo perse.
*
Al centro della silloge L’ombra dell’infanzia di Silvia Rosa, si colloca la narrazione di una vicenda di abusi infantili che, attraverso la reiterazione ossessionante di circostanze e dettagli, sembra simulare non solo il protrarsi delle conseguenze in quell’ormai lontana stagione della vita, ma il suo incessante riverberarsi nel tempo, quasi che passato e presente siano separati da un labilissimo confine da ristabilire faticosamente volta per volta.
A monte di quest’ultimo esito poetico sul tema della violenza, va collocato un lavoro di ricerca che da tempo spinge l’autrice a indagare in ogni possibile direzione testimoniale (romanzi, film, documentari, interviste, saggi) fino ad approdare a quel sentimento di stupita gratitudine, che sempre accompagna il ritrovarsi rispecchiati in un’altra scrittura, suscitato dalla lettura di Triste Tigre di Neige Sinno, dalla quale, come lei stessa scrive nella nota finale, attinge citazioni e termini, cosa che le permette di attuare un serrato confronto con una pluralità di destini che, per quanto accomunati da uno stesso trauma, volgono verso esiti diversi. Del resto è già sufficiente la dedica, che recita: Alle sopravvissute, a stornare l’idea di un “io” invadente e a stabilire da subito un “noi”, assertore di sorellanza e condivisione.
(…)
La rivisitazione radicale del proprio sé implica una decostruzione, a monte, di ogni ovvietà e ipocrisia del linguaggio corrente, soprattutto quello del maschio aggressore che lo userà in modo falso e ambiguo a propria discolpa. Bisognerà tenerlo in conto, senza illudersi che qualcuno che non abbia vissuto le stesse esperienze possa comprenderle fino in fondo, come sottolinea l’autrice nella sezione dedicata alle “sorelle” («Sorelle mie, abbiate pazienza, / non possono comprenderci, e per questo non sanno / quel che dicono»).
Distrutte per sempre la gioia e la leggerezza, crolla, inevitabilmente, anche il lessico infantile nella nominazione del mondo: la poeta lo carica di lemmi grevi, luttuosi («macerie, cieli duri, lacrime acide, corrosive, chicchi d’uva avvelenati»), inventa metafore dolenti («sono un guscio svuotato / nel becco impietoso d’un corvo») e si avvale di una simbologia trasfigurata da una fantasia compassionevole, trovando la figura dell’infanzia dissacrata nell’uccellino che le viene in sogno «con le ali spezzate, senza / acqua né cibo».
Del resto nei poeti tutti, che “fanno” la realtà attraver- 83 so le parole, il primo dovere etico è quello di concepire un linguaggio che diventi strumento di elaborazione e risignificazione divergenti, rispecchiando una verità più intima e profonda di quella che la superficie della realtà sembra suggerire. Tale proposito è evidente già nel testo d’apertura che contiene tutti gli elementi dissonanti di questa scrittura coraggiosa, la quale veicola un forte messaggio che non bisogna esitare a definire politico, nella misura in cui è necessario credere ancora che politica ed etica siano aspetti complementari del bene individuale e sociale. Quest’opera costituisce un esempio del fatto che non esista tema, per quanto crudo e doloroso, che i poeti non possano e non debbano far risuonare in versi, simbolizzando, metaforizzando, trovando connessioni verbo-semantiche inusitate, in una sola parola: cantando.
(dalla postfazione di Franca Alaimo)
*
Silvia Rosa nasce a Torino, dove vive e lavora come docente. Ha esordito in poesia nel 2010 con il libro Di sole voci (LietoColle), a cui sono seguite le raccolte poetiche SoloMinuscolaScrittura e Genealogia imperfetta (La Vita Felice 2012 e 2014), Tempo di riserva (Ladolfi 2018) e Tutta la terra che ci resta (Vydia 2022). Ha curato i volumi antologici: Bestie. Femminile animale, di cui è anche coautrice, e Confine donna: poesie e storie di emigrazione (VAN Editrice 2023 e 2022); Maternità marina (Terra d’ulivi 2020), con sue immagini foto grafiche; Italia Argentina ida y vuelta: incontri poetici (La Recherche 2017), per il quale si è occupata anche delle traduzioni in italiano. Ha scritto il saggio di storia contemporanea Italiane d’Argentina. Storia e memorie di un secolo d’emigrazione al femminile (1860-1960) (Ananke 2013) e la raccolta di racconti Del suo essere un corpo (Montedit 2010). Le sue poesie sono state tradotte e pubblicate in diverse lingue, tra le altre: spagnolo nella silloge Tiempo de reserva (Ediciones en danza, Buenos Aires 2022), romeno nella plaquette Treceri (Editura Cosmopoli, Bucarest 2023) e inglese nell’antologia Look what I did about your silence (El Martillo Press, Los Angeles 2025).