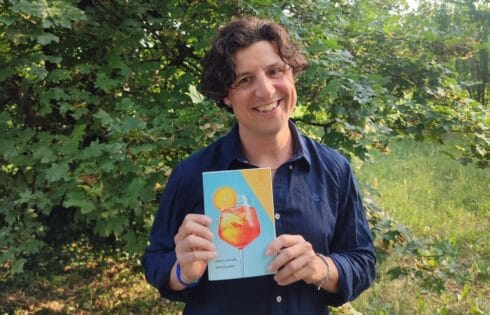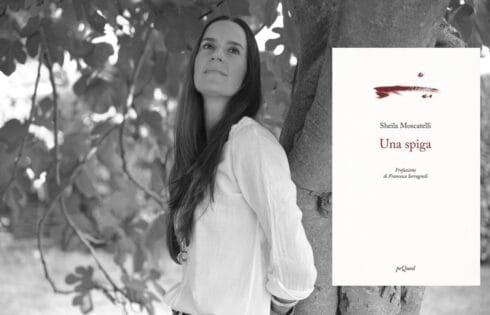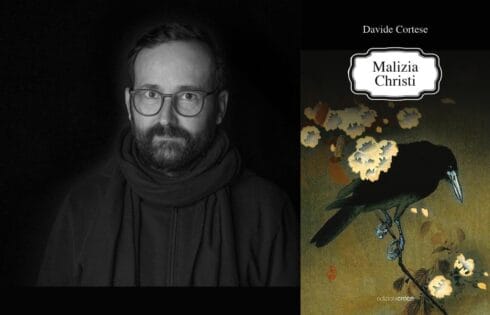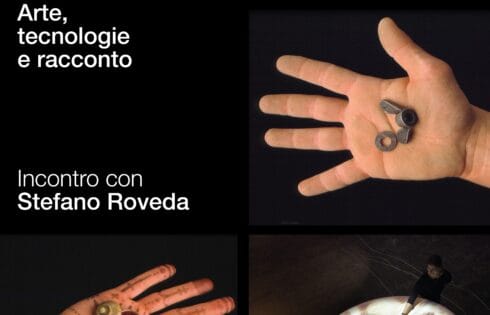tre domande, tre poesie
“Verso dove muove la furia visionaria di Marco Maraldi? L’oltrepassamento, che costituisce il movimento essenziale del libro, non ha la leggerezza del viaggio o il compiacimento del tentativo introspettivo. L’oltrepassamento chiede di estinguersi in una figura che lo ricapitoli; Maraldi non fa che pensare l’éschaton che compie un destino. Né fato né disgrazia, il finire coincide con il disvelamento del senso del destino o con la scoperta del suo nulla. […] L’impressione è che non esista un soggetto empirico – un io, una biografia, una esistenza. Esiste solo un soggetto assoluto che tratta l’esistenza e il mondo come forme sacrificate perché ascendano al loro silenzio”, dalla prefazione di Lorenzo Chiuchiù per introdurre la nostra intervista.
Pariamo dal titolo: qual è stata la scintilla che ha portato il tuo “Assalti”, meglio: in che modo la (tua) vita diventa linguaggio?
Cara Grazia, quello che posso dirti è che una parola che non avesse come suo momento costitutivo un’apparizione non decisa da me, sarebbe una parola autoreferenziale: sarei io a decidere che lei esiste. Ma se io decidessi liberamente che una parola esiste ogni espressione costituirebbe un atto verbale nella mia autoreferenza. Ogni espressione sarebbe arbitraria e prevedibile, un’estrinsecazione del mio io nello scrivere. La via che ho dovuto imboccare è un’altra: in Assalti la parola la si pensa dopo che è accaduta, non è ostaggio del mio arbitrio. Voglio dire che non posso decidere di me stesso quando io stesso sono frutto di decisione. Le porte si aprono solo dall’interno e offrono alla sguardo ciò che sta dietro. Tuttavia non è sufficiente al dono avere un destinatario; quest’ultimo deve esserne capace. Questa capax amoris esige da parte del destinatario una natura omogenea alla natura del dono che a lui proviene, nella misura in cui il dono non trova ciò che ama, ma lo costituisce nell’istante stesso in cui gli si offre. Il conosciuto allora può mostrarsi per quello che è realmente nel soggetto conoscente. A questo punto pensare e pensare la cosa donata è la stessa cosa, come ho provato a spiegare nell’epilogo del libro, e come provo a ripetere ora più discorsivamente. Per rispondere alla tua domanda credo sia necessario chiarire la logica che ha mobilitato la scrittura, a mio avviso comprensibile soltanto se si assume il portato concettuale del termine re-velatio nella sua duplice accezione negativa e intensificativa. Solo lo sposo ha il diritto di alzare il velo della sposa. Quando lo sposo alza il velo la sposa gli si dà come impossedibile da lui, e lui la scopre diversa da come la ricordava. Il fatto che la sposa si riveli non è la negazione dello sposo ma la comunione con lui. A quel punto l’amore, comunicandosi, sottrae le ragioni del proprio comunicarsi permanendo nel suo inviolabile mistero di libertà. Ri-velare significa propriamente proteggere la sovranità del dono, che in quanto dono non si nasconde ma comunica ragioni che l’altro non arriverà mai a possedere, ma senza le quali la sua esistenza sarebbe un niente. L’unità dei due significati non sacrifica la reciproca identità, ma la consacra. La signoria del dono sugli amanti, tuttavia, non può essere soltanto dichiarata. La rivelazione non desterebbe alcun interesse nella creatura se questa non trovasse in essa definito anche il senso della propria esistenza. Senza l’altro che mi manca e che mi parla io non sono me stesso. La parola che l’altro mi rivolge è già la presenza di tutto ciò di cui posso fare esperienza. Uomo e mondo, intelligenza e essere vivono in originaria coappartenenza.
Il titolo del libro rimanda precisamente all’esposizione del soggetto a una potenza che decide della sua esistenza: una parola ricevuta e ridata. È il colloquio in cui la dualità dei parlanti è abolita e ricondotta nella parola stessa. Il compito della scrittura è rendere conto di questo avvenimento, con parole che parlino della parola. L’evento ha per contenuto una comunicazione, il protagonista della quale non è un io duplicato, come nel soliloquio umano, ma un altro realmente esistente. Quest’altro, pur parlante, non è distinto dal messaggio stesso perché è il verbo. Questa dinamica temo non si aggiunga alla mia vita ma la costituisca. Se così non fosse la scrittura non sarebbe altro che una proprietà soggettiva, pensata come di altri a motivo di una condizione di alienazione garantita dalla dilatazione del mio io, vale a dire da una volontà di potenza.
Ad oggi, dove sei stato condotto dalla poesia, qual è stato l’insegnamento?
Obbedire. Mi permetto di ricollegarmi alla risposta precedente, quando ti dicevo che la signoria del dono sul destinatario non può essere soltanto affermata. Deve infatti anche essere dimostrata. De-monstratio non significa dominio razionale, ma rivelazione di ciò che si mostra; e: impossibilità dell’esperienza di resistere all’esperienza stessa che ti afferra e ti trascina a riconoscere che dentro l’apparizione respira qualcosa che non si è mostrato. A partire da una presenza offerta nella voce, dentro quella presenza c’è una forza in virtù della quale tu non puoi più accontentarti della pura presenza. La presenza stessa ti trascina a considerare qualcosa che dentro il suo manifestarsi non appare. La chiarezza acceca, l’oscurità rivela. Di-mostrare significa consentire all’altro di esplicare fino in fondo il proprio contenuto. E, soprattutto, garantire all’altro il diritto di non essere deciso dalla mia volontà, ma di comunicarsi custodendo il suo carattere di verità inviolabile dal mio arbitrio. In questo senso ho dovuto obbedire alla presenza dell’altro, nella misura in cui obbedire significa ascoltare.
“È tutto scritto dal cilicio delle palpebre alla gola.”, con un tuo verso per chiedere: le parole bastano alla poesia, la poesia è un destino?
La poesia è un destino in un senso determinato. Assalti è un libro escatologico, come ha sapientemente rilevato Lorenzo Chiuchiù. L’éschaton non designa “ciò che avverrà” – benché non di rado il termine venga impiegato in questa accezione – ma l’irruzione nel tempo di una realtà definitiva, non come una fase che segni un mutamento rispetto a uno stato precedente. Non si tratta tuttavia della fine della storia, ma del fine realizzato della storia. Tale definitività non è però statica. Il fine implica l’esperienza di ciò che si offre come inesauribilmente nuovo. Il fine realizzato non brucia il discorso come non esaurisce la storia, ma inaugura una parola nuova in forza della sua inesauribilità e non in virtù della sua ripetibilità. Il verso che tu hai citato situa il processo escatologico, che sovrappone gradatamente un tu non imposto dalle circostanze a un io dismesso, non proiettato nella storia. La menzogna che la pluralità produce ovunque invoca la necessità di instaurare nuovamente un’interlocuzione. Il fine realizzato mostra che l’altro che mi parla non esiste per una mia concessione, ma esiste in forza di sé. Se la voce dell’altro non è tale in forza di sé e non mi si impone, non ha in sé la forza dell’evidenza – allora è una mia interpretazione innocua. Un altro che esiste perché io glielo concedo non è realmente un altro. Senza irruzione definitiva della grazia posso versificare finché voglio dell’altro, ma egli sarà sempre e solo una mia concessione. L’altro è altro quando non dipende da me. Allora la parola non può esaurirsi nel dono che fa di sé, e in questo suo accadere l’uomo è ricreato conformemente alla misura della sua libertà, che consiste nell’esporsi totalmente a un’azione che ne costituisce il fondamento e che non entra nella successione dei luoghi, nella serie dei giorni e delle ore.
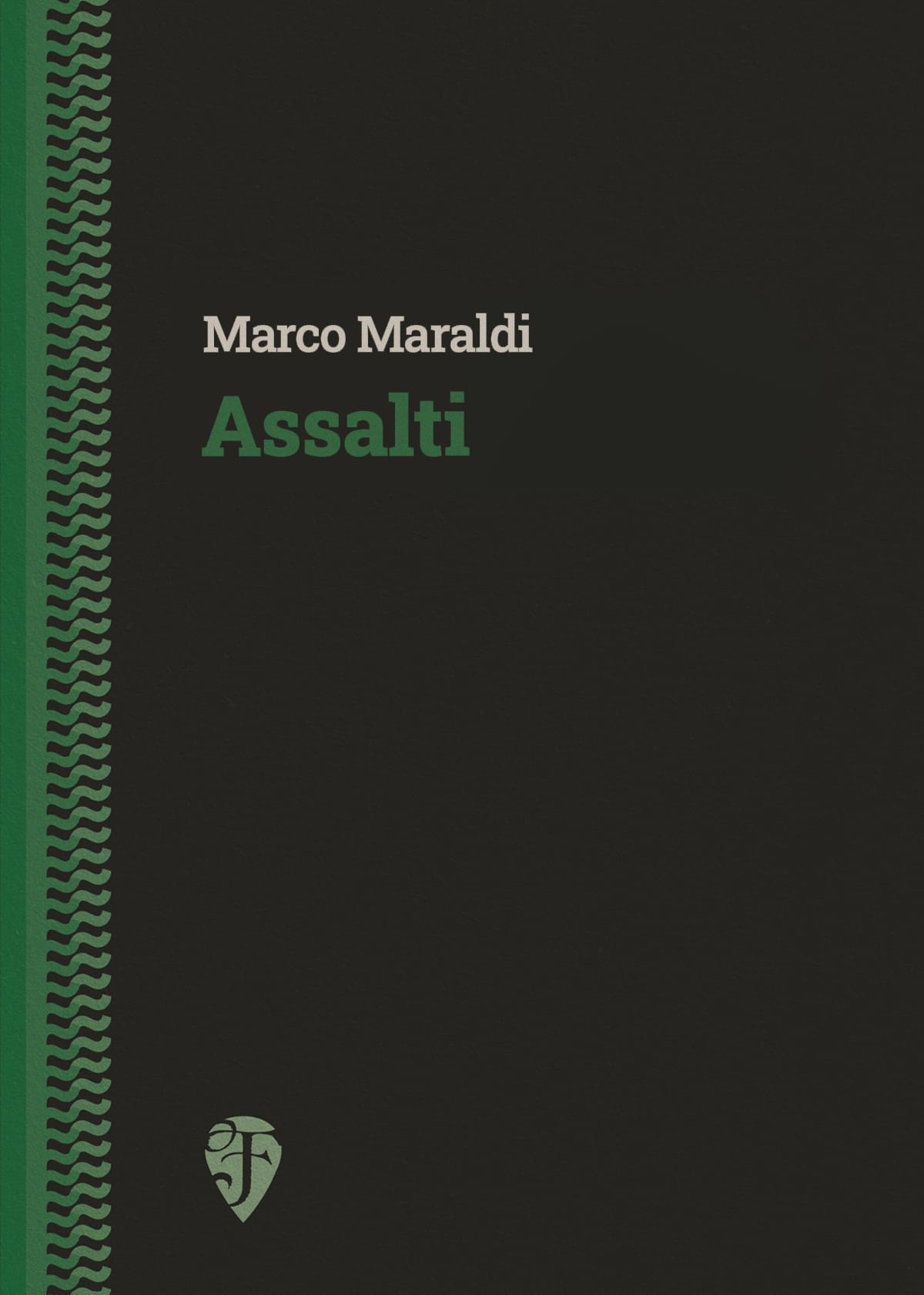
Mi chiedi infine di condividere la prima stesura di una poesia di Assalti, in modo da appuntarne le differenze che ne rifletterebbero da un lato l’esperienza diretta non rielaborata dalla riflessione; dall’altro il mio diverso atteggiarmi davanti a un singolo testo. Temo però che il procedimento darebbe pochi frutti: ho scritto Assalti in un paio di giorni, cui hanno fatto seguito due anni di riscritture che risultano trascurabili se l’ultima di queste – quella pubblicata – sembrerebbe una trascrizione fedele della prima. Rincresce soltanto che si sia conservato un testo eliminato fin dalla prima redazione e sempre escluso dalle successive, come cosa provvisoria e imperfetta quale è, vale a dire un mio errore. Te lo mando insieme a due poesie del libro. Non aggiungo altro perché mi sembra di aver parlato anche troppo.
(Inedito)
In mille materie
l’idea di un brivido mi venne in mente per sbaglio
forse da nessun luogo.
Chiuso in tutti gli angoli della gola
la violenza estiva è popolata dalle potenze degli esordi.
da Assalti
L’eterno ti intona senza perdono.
Stanato alla tenebra
una mente ristagna sul pavimento.
Sono tutte le gole che non conosco.
XI. Sei solo un’eco della divinazione. Non essere riconsegnato alla volgarità di avere un nome. Nessuno in te all’infuori di me – i fiori della grazia sono brace in bocca. Hanno cieli negli occhi e chiodo notturno. Tu rinasci nel senzanome. Dormi adesso, dormi – le parole sono piene di punte.
—
Marco Maraldi (Mirano, 1995) è laureato in Filologia Moderna. Ha esordito nel 2021 con la silloge Prima della luce (Kolibris). Suoi inediti sono apparsi su Atelier Poesia, Margutte, Barbarico Yawp, Inverso, Poesia ultracontemporanea, Poeti Oggi, Bottega di Poesia curata da Maurizio Cucchi su la Repubblica. Svolge un’attività di ricerca nell’ambito delle scritture delle sante mistiche d’Occidente.