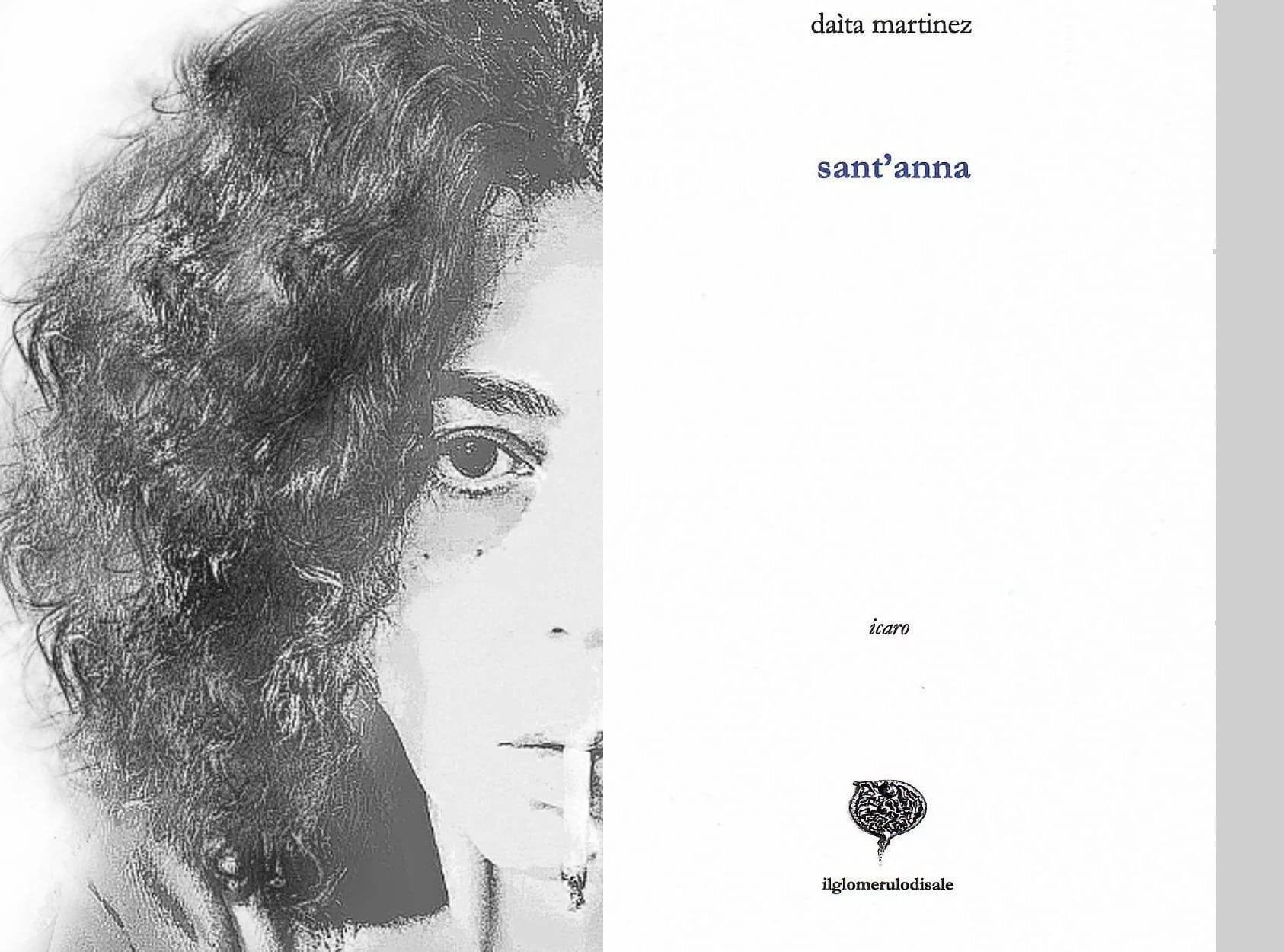Poesia e fulgore, rubrica a cura di Franca Alaimo
Bisognerebbe indagare di più sull’affinità tra la scrittura di Daita Martinez e quella di Mario Benedetti ‒ confermata fra l’altro dall’ammirazione di quest’ultimo verso la poesia dell’autrice palermitana già dal suo esordio ‒ per capire meglio quel salto della struttura sintattica che li caratterizza entrambi e gli strumenti di cui si servono per annodare in altro modo legami fra le cose e sé stessi, secondo il ruolo materno di ogni parola che ne partorisce altre per prossimità sonora.
Le parole dell’autrice, infatti, sembrano chiamarsi per sussulti di suoni che si germinano dal bianco del silenzio scegliendo come specchi i fiori del giglio e della magnolia per farsi sguardo retroattivo, intanto che cresce dentro il dolore del tempo presente. Fiori che, coincidendo con fiotti memoriali, aspirazioni interiori e simboli, più che condurre il lettore all’aperto, sembrano proiettarsi come ombre in uno spazio chiuso, il cui accesso, come l’adyton nei templi greci, è riservato solo all’officiante-poeta che lo gestisce, celebrando i suoi riti grazie a formule segrete in una sorta di ossessiva ripetitività atta alla convocazione di una presenza sovrumana e alla purificazione del male. In questo modo si giustifica l’ambiguità fonetica, catturata in età puerile, tra la chiesa palermitana di Sant’Anna e la clinica D’Anna aperta anche alla ricezione di pazienti con disturbi mentali.
La stessa casa è, insomma, un luogo oscillante fra sacralità amorosa e prigionia dolorosa. Perfino le pause che spaziano i versi sono somiglianti, dal punto di vista psichico, a spezzature e singulti mentali, e, dal punto di vista espressivo, a disancoramenti generati dall’impossibilità di raggiungere con i segni tracciati sul bianco del foglio il cominciamento del tutto, l’azzeramento di ogni male e colpa.
Accade, però, in certe pause del cuore che il corpo smetta di essere prigione nella prigione, e, pervaso dalla percezione olfattiva dell’ odore del silenzio, si spalanchi alla levità dei ricordi infantili e tutto il mondo affiori intero nella sua bellezza: stelle, anatroccoli, una piazza barocca, il chiarore albale si fanno preghiera al Padre (il celeste e quello terreno già scomparso), all’angelo custode e alle cose che trattengono il mistero più ampio della bellezza del mondo: la rugiada, il sole, l’albero, la luce lunare, i merli; così che l’atto del contemplare scivoli verso quell’ «abbaglio dell’infanzia perduta» di cui parla Enrique Molína a proposito della poesia della Pizarnik.
Forse la figura più potente di questo abbaglio è per la poeta la volpe, che non incarna nessuno dei vizi che le si attribuiscono nella letteratura, ma corrisponde ad una percezione reale e improvvisa di fascinazione rimasta nella memoria; casomai, se si vuole cercare un parallelo, si potrebbe pensare alla volpe de Il piccolo principe che insegna la cura dei legami affettivi, da trattenere nella memoria anche nell’allontamento.
Tutto questo corrisponde a una tentazione di regresso fino alla cancellazione stessa del reale a favore di una vittoria del tempo onirico infantile, nel senso latino della parola in-fans.
È così che il bianco, tante volte ripetuto, diventa anche emblema di vuoto, nullificazione del proprio sé, cancellazione, se non di svanimento nel bianco iniziale, anzi desiderio di non essere nato, secondo la pronuncia di alcuni versi di Franca Maria Catri, scelti per l’exergo quale messaggio riassuntivo ribadito dal distico dell’autrice: sorgimi laddove sola immergo / il grembo candido del distacco.
Il lutto in Daita Martinez si tiene, tuttavia, lontano da un’iconicità perturbante, ma sembra nascondersi, come un infante impaurito, e accoccolarsi negli spazi vuoti della costruzione sonora dei versi, in quelli che Stefano Dal Bianco nella prefazione a Tutte le poesie di Mario Benedetti, editate dalla casa editrice Garzanti nel 2017, definisce «groppi», ossia «nei buchi neri della lingua, in ciò che manca, nelle giunture vertiginose e nelle ellissi, in quanto carenza o impertinenza dei nessi connettivi, e insomma nel recalcitrare della sintassi, nel vessillo della lirica mantenuto alto», nonostante lo sprofondamento nella dimensione del buio e dell’assenza.
La liricità del dettato cura, infatti, come in Alejandra Pizarnik, il luogo della ferita e trasforma il versificare in una cerimonia troppo pura. Perciò, come canta Daìta Martinez, sotto la casa del / merlo che sia ancora tempo il fiore / bagnato di sole il primo dolcissimo / umore sceso al seno per vocazione. Un altro piccolo volatile, il passero, che alza le sue note nel silenzio albale, compare in un secondo testo a sottolineare il momento in cui la sua voce e quella dell’autrice si congiungono sulla pendice del silenzio per celebrare il sacro della vita che inizia.
Leggendo i testi della raccolta, sembra infatti di percepire la presenza di un fantasma, che forse sarebbe meglio chiamare l’ombra dell’anima: la Solitudine che afferra le ali di psiché e la costringe nella sua prigione, e allo stesso tempo, come una maga, la dilata in un intreccio soave di suoni che sognano tenerezze mancate.
Ne consegue una tanto più struggente percezione della presenza silente del sovrumano nel tocco consolatorio degli angeli, nella grazia della maternità della Vergine, in cui si fonde anche la realtà fisica della propria madre, anche lei come la figlia e con la figlia avvoltolata in una dolente prigionia. E però entrambe oranti. Ed è il termine “maggio”, così ricorrente all’interno della tessitura temporale di questa poesia, il filo che cuce insieme la nascita dell’autrice, quella del padre, e Maria (che rimanda alla figura della madre) celebrata nel mese delle rose, Lei stessa mistica rosa, simbolo di verginità e di amore.
Chiude la silloge il poemetto breve che dà il titolo alla silloge: Sant’Anna, il testo più complesso ed oscuro, introdotto da tre riflessioni di Antonella Lumini, in cui il lettore trova termini cari all’autrice: il silenzio, l’innocenza, la caduta, il bosco, la solitudine. Si potrebbe definire una sintesi biografica in versi, sebbene la vita (bios) raccontata sia più quella dell’anima che del corpo, presente nella nominazione delle parti che lo compongono (faccia mani piedi capelli occhi seno e così via) da considerare, tuttavia, soltanto quali spazi d’accoglienza del vuoto lasciato nella casa dal padre non più vivente. In questo senso quest’ultimo testo sembra continuare il canto del libro precedente Nell’ora dell’aurora.
Recita, dunque, così l’epilogo purissimo e malinconico: sono sette anni solo sette noci i denti / che nascondo sotto al cuscino per l’illusione / di un dono per un furtivo abbraccio alle spalle / che sappia per un solo attimo farmi fiatare la gondola del cuore ha poche onde il mio cuore / e nessun pontile per l’attracco.