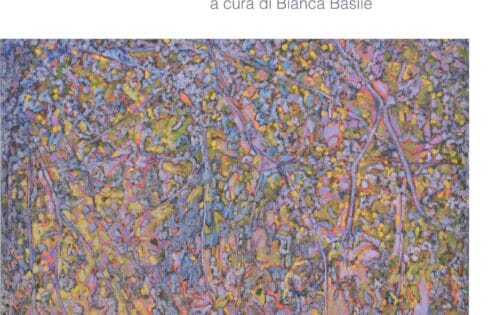«Ora che con incerti passi/ siamo giunti nei luoghi di confine/ tra le ore che sono già trascorse/ dai giorni che ancora devono/ venire porgetemi le manine vostre/ affusolate sicure e proteggetemi/ dalle intemperie del reale/ mentre vi narrerò la favola/ aurea del kutik…». Versi di Carmelo Panebianco (scelti da “Le parole di un vecchio nonno”), per segnalare la lettura di “Recinto infinito”, pubblicato da “Alessandro Prevosto Editore”, nella collana “L’oceano e la luna”, diretta da Giuseppe Conte che, mirabilmente, dice: «C’è una pronuncia alta, profetica, visionaria, sciamanica che rende questo libro un libro di antica e attualissima grandezza. L’autore inscena, celebra, canta un suo mondo poetico finissimo di presenze e di ombre. Il lettore conoscerà il Kutik, giardino, memoria, infanzia, inferno, paradiso perduto, nodo centrale della poetica di Panebianco, si imbatterà in un linguaggio da classico greco e in inserti di un siciliano popolaresco e fiabesco, in momenti lirici stupendi. E incontrerà figure come la Sfinge, Hermes, Psiche, Salomè, Orfeo, Medusa, in un percorso sapienziale dentro il mistero dell’anima e del cosmo. A rendere questo libro ancora più mirabile, si affianca a quello tragico e simbolico, un tono familiare, domestico, dolcissimo in cui un vecchio nonno si rivolge alle sue nipotine… C’è un leitmotiv che innerva in sé tutto il libro: la coscienza che tutto ciò che appare svanisce, e poi risorge».
Quello di Panebianco, piace ribadirlo, è un lirismo colto, volto al contagio dell’esperienza esistenziale, un lirismo che, nella suggestione della parola, coniuga laica devozione, dimensione conoscitiva e “luce mutevole”. L’autore, afferrandone il senso, attraversa il tempo che, lento, «scivola immacolato», etereo, volteggia sul foglio come nella «fitta rete astrale». Avanza, come l’Autunno malinconico, nella chiara consapevolezza che «siamo e non siamo/ contemporaneamente». Pellegrino, come il gelso e il fico, recita «la preghiera/ mattutina alla grande madre terra». Risplende l’istante, «falena che s’immola/ per sete santa d’eterno».
Qual è (ad oggi) il significato dello scrivere poesia?
«Credo significhi ricercare un “senso dell’esistere”, per sé e per gli altri, attraverso un approccio con la realtà non mediato dalla sola “ragione” per restituirlo con l’unico mezzo che, da sempre, contraddistingue l’essere umano: il linguaggio».
“Delicato come la memoria,/ nella stanza il profumo di mimose”, con questi versi per chiederle: qual è il ruolo dei “ricordi” nella (sua) poesia?
«La poesia si nutre della memoria dell’io/soggetto e di quella “collettiva”. Se la memoria sul piano umano è il passato, nella dimensione poetica è (il) “presente”. Nel mio caso, la memoria credo abbia avuto il ruolo di ricerca di quel “senso dell’esistere” personale e paradigmatico, ai fini di una riappropriazione di se stessi, del proprio mondo».
“Recinto infinito” è concepito in sei sezioni (“Alma mater”, “Dittico familiare”, “Rapsodia fluviale”, “Alberi custodi”, “Preludi” e “Requiem Hybleo”) accostate da un “fare” (poiéin) come espressione estrema di consapevolezza («segui la luce del costato/ Hermes ti guiderà a imboccare/ il giusto sentiero dei giusti»). Panebianco, per dirla con Giorgio Ficara, la cui nota scorta il volume, è “Platonico come un umanista del Quattrocento, ma agile e mobile fra materia e spirito come un contingentista moderno”.
Sceglierebbe una poesia per salutare i nostri lettori?
«Scelgo pochi versi tratti dalla poesia “La sfinge”: “L’ignoto è ala di poiana/ nella stagione della polvere…/ straniero non profanare/ l’ordine del muschio ricorda/ che ciò che nasce svanisce/ ciò che nasce risorge”».
(la versione ridotta di questa recensione-intervista a cura di Grazia Calanna, è apparsa sul quotidiano LA SICILIA del 13.07.2025, pagina Cultura, rubrica “Ridenti e Fuggitivi”).